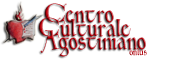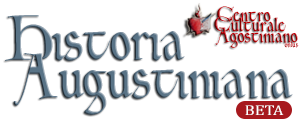Secondo un dato legato alla tradizione l’insediamento fabrianese sarebbe sorto attorno alla chiesa di Santa Maria Nova, fondata nel 1216 da Gualtiero di Ruggero Chiavelli e inglobato nella cinta muraria per iniziativa di suo figlio Alberghetto. La fabbrica del Sant’Agostino fu iniziata dai frati alla fine del Duecento e ancora non conclusa nel 1311. L’osservanza regolare vi fu stabilita a partire dal 1452. Il complesso fu demaniato nel 1808, la chiesa riaperta al culto nel 1822, e di nuovo soppressa nel 1866. Nel 1924, dopo decenni di abbandono, essa fu di nuovo restituita al culto e affidata al clero diocesano, mentre l’antico convento è dal 1874 adibito a ospedale.
La chiesa presenta un presbiterio a terminazione rettilinea. Il portale, a tutto sesto e strombato su colonnine, dovrebbe risalire al primo Trecento. Questo portale servì da modello per quello della scomparsa chiesa di Sant’Agostino a Camerino (oggi murato nell’Annunziata) e per quello dell’omonima chiesa matelicese. Alla fabbrica originaria potrebbero appartenere, oltre al portale, alcuni resti come le arcate a sesto acuto del portico all’ingresso del chiostro, l’intera parete laterale in cui restano leggibili le tracce delle originarie monofore aperte negli spazi della contraffortatura a lesene, l’abside in opera muraria in pietra e le due cappelle che affiancano la tribuna, con resti di affreschi del primo XIV secolo. Ulteriori dati riguardano le vicende architettoniche del complesso tra il Trecento e il Quattrocento. Si ha notizia della consacrazione di cinque altari minori nel 1360, della costruzione del refettorio nel 1416 e di una nuova consacrazione della chiesa da parte del vescovo di Senigallia nel 1443, in seguito a un ampliamento. L’edificio è stato interessato da rimaneggiamenti anche in epoca moderna: al 1645 risale la facciata sul chiostro, oggi ulteriormente rimodernata, mentre ugualmente degno di nota è il radicale rifacimento dell’interno nel 1769, resosi necessario in seguito a un terremoto che aveva danneggiato l’edificio l’anno precedente.
Tra le opere d’arte si segnalano resti di un ciclo di affreschi tardomedievali con echi della scuola riminese (Storie di sant’Agostino e Storie della Maddalena): dipinti nelle cappelle ai lati della tribuna e restaurati nel 1933, essi sono stati attribuiti all’anonimo trecentesco Maestro di Sant’Emiliano in una sua fase matura. Ulteriori affreschi, strappati e oggi collocati nella Pinacoteca civica, sono stati assegnati da alcuni studiosi a un anonimo artista duecentesco di formazione umbro-toscana con influssi giunteschi, da altri al pittore fabrianese del primo Trecento Francesco di Bocco. Una tavola di Allegretto Nuzi con i Santi Nicola da Tolentino, Agostino e Stefano (post 1372) è stata anch’essa trasferita nella Pinacoteca civica della città. Le tele che ornano gli altari sono quasi tutte del fermano Filippo Ricci (1768) fatta eccezione per due, rispettivamente, dello jesino Aquilini (1642) e di Michelangelo Miliani, mentre i tre quadri del coro sono del romano Giuseppe Cades (1750-1799) e provengono dalla non più esistente chiesa di San Francesco.
Nei dintorni della città si stabilirono, trail 1810 ed il 1816, alcune monache agostiniane provenienti da Sigillo, dove tornarono dopo la soppressione del convento. In località Malvano di Nebbiano esistette invece, fino all’Ottocento, un oratorio agostiniano intitolato a santa Monica, divenuto poi proprietà privata. ù
Paolo Cruciani