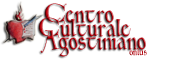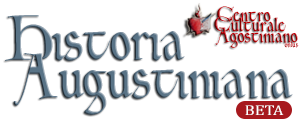La più remota data di fondazione del convento agostiniano di Jesi si fa risalire - sulla base delle notizie riportate dal Baldassini - al 1100. L’autore parla di Agostiniani Calzati ai quali il Comune donò, assieme a «una certa quantità di terreno» (circa tre coppe di terra), l’antichissima chiesa di San Luca, sulla base di «un libro antico di quel Convento»: «Illius funndatio circa annum 1100 contigit. Urbe donante fratri Michaeli Esino Ordinis Eremitarum S. Augustini ecclesiam Sancti Luce cum tribus terrulis in aliquale juvamentum pro victu Eremitarum». Anche se la data appare evidentemente un po’ precoce, non si può escludere che possa trattarsi di un primitivo insediamento extra urbano, ubicato probabilmente ove ora sorge il convento dei Cappuccini, poi seguito da un inurbamento da far risalire al 1247, quando fu donata dal Comune (il 17 di agosto) l’attuale chiesa di San Luca su piazza Colocci, come riportato dal Bullarium (c. 58, n. 62) dell’anno V del pontificato di Innocenzo IV: «Pro aedificatione ecclesiae Brictinorum in civitate Jesi». Nella Relazione del 28 marzo 1650, relativa alla ricognizione dei conventi agostiniani in vista della loro soppressione, si fa riferimento alla data dell’XI secolo come riportato da una carta del 1526 «in uno dei libri antichi del monastero». Nella stessa relazione il complesso è così descritto: «Il monastero è di struttura di lunghezza piedi n.142, di larghezza piedi n. 46. Vi sono undeci camere semplici con quattr’altri appartamenti, doi de quali sono di tre camere e l’altre due di quattro. Vi sono parimente refettorio, cantina, dispensa, legnaro, barberia, granaro con quattro stanze. La chiesa è di lunghezza piedi n. 92, di larghezza piedi n. 42. Il monastero è posto in mezzo della città fra due piazze, da una vi è il palazzo dell’Ill.ma Comunità, dell'altra il palazzo dell’Ill.mo Governatore». Non v’è dubbio che trattasi qui dell’isolato compreso tra le attuali piazza Spontini e Colocci, e che la chiesa descritta sia approssimativamente quella che attualmente ancora si vede.
Già nel XV secolo la chiesa di San Luca (o Sant’Agostino) - originariamente di forma gotica a tre navate, officiata dagli Agostiniani che ne occupavano anche il convento - aveva ospitato la Capella Lombardorum curata dagli immigrati lombardi sin dal 1472. Tra la fine del XV e gli inizi del XVI, la chiesa venne ristrutturata su modelli rinascimentali di ispirazione fiorentina. Sotto la protezione della famiglia Colocci, possidente del palazzo attiguo (e in particolare del grande umanista e archeologo jesino monsignor Angelo Colocci) - che ne fece la propria chiesa gentilizia, al punto che i membri della famiglia ebbero il privilegio di poter assistere (dal 1551) alla Messa tramite una finestrina aperta nel muro di confine tra la chiesa e il loro palazzo. Nel 1556 i frati di Sant’Agostino concedono a Ippolito Colocci l’appoggio del muro del palazzo di famiglia su quello della chiesa che viene dichiarato muro divisorio comune; precedentemente le case dei Colocci erano separate dalla chiesa da un vicolo: «[...] andronem seu vicum qui est inter eius domos in civitate. Esj prope ecciesiam Sancti Luce».
II tempio fu arricchito, tra XV e XVI secolo, di opere d’arte, fra le quali si ricordano le pitture di Pieramore di Bartolomeo, dell’Indivini, dell’Agabiti, di Andrea da Jesi. La pianta finale, oggi conservata, è a tre navate con volte a crociera modulari (rapporto 2/1) a sedici cappellette absidate, conclusa da un’abside emicicla; la navata centrale è spartita in quattro volte a crociera. Le cappelle furono elevate al numero di diciassette (attualmente, infatti, le nicchie laterali nella navata sono sedici, tre risultano oggi tamponate, più quella absidale dell’altar maggiore), fra le quali quelle volute da Angelo Colocci sono: quella di San Rocco, quella dedicata a san Giovanni (detta della Madonna di Loreto), della quale avevano il giuspatronato, e quella gentilizia dei Colocci nella tribuna grande della chiesa. Il complesso era articolato su un intero isolato urbano, su due chiostri separati dal corpo ecclesiale da un passaggio voltato che collega ancora le due suddette piazze. Nel 1543 la chiesa si arricchì di un nuovo campanile realizzato su disegno di un Maestro Albertino da Cremona, proseguito e completato da Maestro Guido di Giovanni da Bellinzona e da Antonio di Silvestro da Castiglione d’Adda. La sua forma è ricordata a base quadrata, con tamburo terminale ottagono sopra la cella campanaria e cuspide ottagona con una sfera di bronzo e croce. Quando il campanile fu demolito nel 1878-1880 - a detta dei cronisti - era il più antico e nobile della città. La facciata attuale, su due ordini con frontone centinato su volute di raccordo, è opera modesta dei primi anni del secolo XVII (forse compiuta nel 1639), realizzata su schemi compositivi tardomanieristi non bene assemblati, nei quali si evidenziano singolarmente i soli finestroni (due di differenti misure) a fastigio curvo e spezzato, che vennero ripresi poco più in là nelle coeve finestre del palazzo Guglielmi, sul lato nord-occidentale della piazza Colocci (già di San Luca). Nel convento jesino si tennero due Capitoli provinciali, nel 1730 e nel 1772. Il convento, restaurato per l’ultima volta nel 1830, subì - tra la fine del XVIII secolo e l’Unità d’Italia, come altrove - varie soppressioni; chiuso nel 1867, venne riaperto provvisoriamente nel 1873 con cinque religiosi residenti, per poi essere definitivamente abbandonato alla fine del XIX secolo per mancanza di vocazioni. La chiesa, attualmente di proprietà comunale, usata già a bottega e infine a magazzino, attende oggi un accurato restauro che ne rimetta in luce i probabili affreschi scialbati e lo restituisca a più consoni usi pubblici.
Fabio Mariano