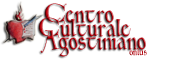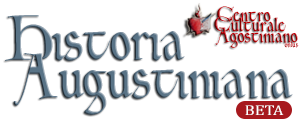Il Torelli, con il solito argomento della precedenza agostiniana sui Francescani, pone una datazione piuttosto alta (ante 1226), contestata da Pompeo Compagnoni, vescovo di Osimo e di Cingoli, il quale da una vendita degli Eremitani di Sant’Agostino del 22 novembre 1296, rogata «in oratorio dictorum fratrum posito in burgo Sancti Laurencii», argomenta che i religiosi fossero a quel tempo nel borgo suddetto ma non avessero ancora la chiesa di San Lorenzo, di possesso avellanita almeno fino al 1308. Cicconi sostiene che gli Agostiniani fossero fuori città probabilmente dalla metà del secolo XIII o in epoca addirittura anteriore, ma già nel 1308 essi erano ancora più prossimi alle mura, per il riferimento statutario sulle esenzioni dalla colletta accordate agli Eremitani di Sant’Agostino su alcune case di loro proprietà e in particolare riguardo a una domus «Ad honorem et reverentiam beati Augustini et omnium sanctorum, statuimus et ordinamus quod fratres Heremite ordinis sancti Augustini de auximo pro domo posita in parrocchia Sancti Petri Fillelique fuit Jacobi Tebaldi, quam dicti fratres emerunt a dompno Clodio, et pro domo alia posita iuxta ipsam domum quam dicti fratres emerunt Guilielmo Benedicti et etiam pro aliis domibus quas in posterum dicti fratres ement pro dicto loco construendo et ampliando in dicta contrata et parrocchia iuxta predictas domos». Questa chiesa risulta peraltro già edificata nello stesso 1308 se in un’altra rubrica si stabilisce «quod via que est in burgo Sancti Petri Filelli videlicet ab angulo ecclesie fratrum heremitanorum usque ad portam Caldarariam, debeat ex panari». Il borgo di cui ora si parla non è più, dunque, quello di San Lorenzo, ma l’altro di San Pietro del Filello poco fuori la cinta medievale. Inoltre, quest’ultima chiesa, collocata a meridione, non era lontana dal locus dei frati, in quanto dalla medesima fonte risulta che «quod ab ecclesia Sancti Augustini usque ad portam Sancti Petri Filelli bibia non labatur nec mictatur nisi subtus terram et per conductum». Nella rubrica XII dello Statuto post 1314 intitolata De viis publicis actandis si delibera inoltre che «dicta via queincipit a domorum scalis predictorum filiorum domini Goncolini usque ad portam Caldariam teneatur potestas facere explanari et dirigi a dictis scalis usque ad portam predictam, et a dicta porta usque ad locum fratruum Heremitarum, et a dicto loco fratruum predicrorum usque ad grappum ipsius burgi Sancti Laurencii ita quod predicta via magis sit abilis et melior accessus quam fieri poterit». Gli Eremitani nei primissimi anni del Trecento possiedono, pertanto, una chiesa dedicata a sant’Agostino che è lecito porre, da quanto è emerso, poco fuori la porta Caldararia (oggi detta «Musone») e molto vicina all'antica cerchia muraria. Almeno nel 1342, comunque, i frati risultavano inurbati nella chiesa anticamente detta di San Pietro de Ceronzio e quindi di Santa Maria Nova e poi di Sant'Agostino, detta ora Santa Palazia per la presenza di un edificio sacro non lontano il cui titolo fu in seguito portato appunto in Sant’Agostino. Come si sa dallo Statuto coevo, dove si dispone che si debba fare «de bonis et pecunia dicti comunis unus cereus de cera valoris et precii trium librarium denariorum usualis monete, quolibet anno infesto asumptionis ipsius beate virginis de mense augusti, qui portari debeat et deferri ad ecclesiam Sancte Marie Nove de Auximo loci Sancti Augustini». Il convento fu soppresso nel 1652 e «alle monache di S. Chiara si unirono altresì i beni de’ frati eremitani di S. Agostino, che montavano all’annua rendita di scudi 130, a condizione però che le suore dovessero adempiere in perpetuo gli obblighi di quella chiesa e che gratuitamente ricevessero all’abito una giovane paesana a nominazione del vescovo».
La chiesa, a nave unica, che ha subito una radicale trasformazione settecentesca, conserva della configurazione trecentesca il prospetto laterale del convento contraffortato, in cui si vedono tracce delle antiche aperture. Il convento è ora adibito a edificio scolastico. È probabile che il complesso sia stato riaperto dopo la soppressione innocenziana, dato che nel 1793 vi erano otto religiosi e ancora nel 1873 aveva tre religiosi. Risulta definitivamente chiuso prima del 1880 per mancanza di vocazioni. Ha dato i natali al beato Clemente da Osimo (1210-1291), Provinciale delle Marche nel 1269 e priore generale negli anni 1271-1274 e 1284-1291.
Si segnala all'interno della chiesa, sull'altare maggiore, la Madonna della Cintura e sant’Agostino (1593) di Ercole Ramazzani.
Tiziana Marozzi