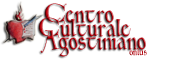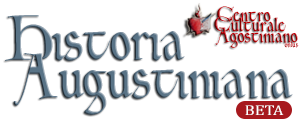Il 18 ottobre 1469 un’immagine della Vergine, dipinta in una piccola edicola eretta nel campo di tal Giovanni di Filippo da Narni, presso una fonte, a circa un chilometro da Macerata sulla provinciale in direzione Macerata-Piediripa, presso l’attuale cimitero, cominciò a operare miracoli, cosicché Paolo II autorizzò il Comune a costruire sul posto una chiesa. Pochi anni dopo fu deciso di collocarvi una comunità di religiosi, e per questo il Consiglio di Credenza scrisse al vescovo, monsignor Andrea De’ Pili, che risiedeva a Roma, affinché invitasse i Serviti, ma il 17 ottobre, avendovi quelli rinunciato, s’insediarono gli Agostiniani della Congregazione lombarda da cui trassero anche il nome di «Padri della fonte». Nel 1508 il Comune affidò agli stessi Padri la cura del lazzaretto della città, adiacente al complesso, con il compito di curare anche l’assistenza del vicino lazzaretto che due anni dopo fu demolito per ampliare il convento stesso. La costruzione del complesso, avviata nel 1550, portò a una duplice controversia che chiamò in causa il medesimo Comune di Macerata sia con la confraternita di Santa Maria delle Vergini, sia con gli Agostiniani. Il dissenso con questi ultimi era stato causato dalla violazione da parte del Comune della convenzione del 1549, con la quale i frati della fonte gli avevano concesso l’oratorio «ad habendum, fructandum et officiandum» in perpetuo, con la clausola che non fosse affidato a nessun altro Ordine religioso. Invece il Comune stesso nel 1562 vi aveva ospitato per necessità i Gesuiti, da poco giunti a Macerata e in attesa della costruzione della loro fabbrica. Altro motivo di forte dissenso era dato dalla pretesa proprietà di una vigna posta vicino al costruendo complesso di Santa Maria delle Vergini. Con l’atto in parola gli Agostiniani riconoscevano al Comune e alla confraternita di Santa Maria delle Vergini la facoltà di far officiare sia il vecchio oratorio che la nuova chiesa a qualunque Ordine religioso, mentre il Comune riconosceva ai religiosi i diritti che essi pretendevano avere sulla vigna come appartenente ecclesiae S. Mariae virginum seu hospitali delli appestati. Alla medesima controversia si riferiscono anche altri documenti, come la protesta avanzata nel 1549 dal sindaco del comune di Macerata, Leonardo Mancinelli, contro l’accordo intervenuto trail vescovo di Macerata, monsignor Riccabella, e gli stessi Agostiniani della Fonte circa la destinazione ad pios usus di una terza parte delle elemosine che i fedeli facevano ogni giorno al menzionato oratorio di Santa Maria. L’importanza del complesso e il ruolo degli Agostiniani si desume dal fatto che Gregorio XIII nel 1582 e Benedetto XIV nel 1742 concessero ai visitatori di questa chiesa l’indulgenza plenaria. Le famiglie maceratesi furono generose verso la nuova congregazione, come documenta anche la Relazione del 1650 che documenta un patrimonio fondiario di 127 ettari di terreno, la quale nel 1596, contava quattordici padri, diminuiti un secolo dopo a cinque.
La chiesa, di vaste proporzioni, divisa in tre navate, era dotata di ben tredici altari. Un grande quadro, posto nell’abside, rappresentava Santa Maria Maddalena penitente. Nell’altare dedicato alla Vergine era posta una grande lastra d’argento che rappresentava, a rilievo, il panorama di Macerata, opera dell’ascolano Pietro Vannini (morto nel 1496). Dell’originaria configurazione cinquecentesca rimangono la facciata policroma della chiesa - realizzata in parte con muratura a parametro a stilatura sottile e con velatura color rosso, intonaco a calce colorato rosso, avorio e celeste per le nicchie e le statue provenienti dai reperti archeologici di Helvia Recina - a paraste toscane intercalate da finestre e da nicchie, priva del timpano a bandiera superiore, che con ogni probabilità fu demolito o andò distrutto durante la ristrutturazione dell’oculo centrale in finestra, e il chiostro centrale, di carattere roveresco con archi a pieno centro su pilastri poligonali decorati dai bassorilievi del maceratese Antonio Piani. Nel 1876 s’iniziò la costruzione del terzo portico e nel 1882, su progetto di Pietro Collina, fu costruita l’ala sud del cimitero. Nel 1810 la chiesa fu parzialmente demolita e rimasero due cappelle laterali alla facciata, delle quali è pervenuta solo quella del lato sud, anche se rimaneggiata. Quella a nord, crollata durante i lavori di demolizione della chiesa, è stata trasformata in abitazione del custode. L’altra cappella si conservò fino al 1948, anno in cui fu ampliata con l’aggiunta di un’abside. Fu ristrutturata ancora negli anni 1960-1970 e dopo il terremoto del 1997.
Nel 1798 i religiosi furono trasferiti dal Governo napoleonico nel convento di Tolentino e qui furono trasferiti gli Scalzi del convento di San Giuseppe. Nel 1800 tutti ritornarono in loco. Nella seconda soppressione del 1810 la chiesa e il convento furono definitivamente chiusi. Le parrocchie del Crocifisso in Corneto e di San Cristoforo di Morica, già riunite sotto un unico parroco nella chiesa di Santa Maria della Fonte, furono trasferite a Santa Maria delle Vergini nel 1811. Nel 1812 il «magnifico e grandioso» complesso di Santa Maria della Fonte fu in gran parte demolito perché l’area fosse adibita dal podestà Lazzarini a cimitero con grande rammarico dello storico Alessandro Maggiori che definì la chiesa "bellissima" deprecandone la demolizione.
Tiziana Marozzi