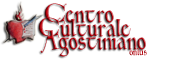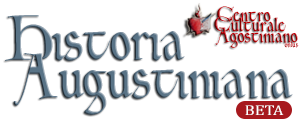Quelle bombe che il 19 giugno 1944 spianarono l’ex convento agostiniano della Cella, «fecero affiorare le venerande strutture della dimenticata sommersa cappella, semidistrutta dalle posteriori costruzioni che interamente l’occultavano... semplice e primitiva cappella, sorta quando, in quella zona, non esisteva l’abitato, ma quasi vi giungeva il mare, lungo il dolce arco del lido che il Promontorio di S. Benigno aveva formato con le sabbie del Polcevera. Ed è tradizione che i pescatori avessero eretto in tempi antichissimi una piccola chiesa sull’arena dedicandola a San Pietro, ed è presumibile che appunto tale chiesa avesse fin d’allora dato il nome alla località. Questa chiesa esisteva nell’anno 725, quando vi furono deposte le Reliquie di Sant’Agostino sbarcate da Cagliari durante la loro traslazione a Pavia ordinata da Liutprando. Che un simile avvenimento abbia introdotto o intensificato il culto per il santo Dottore è facile comprendere, sì da ritenere logica e fondata la tradizione che vuol costruita, perciò, una nuova chiesa sul punto dello sbarco, vicino a quella di S. Pietro, od anche l’ipotesi che sia stata la stessa chiesa di San Pietro, che ne aveva ospitato il corpo, ad assumerne il titolo». Solo la fantasia può entrare nel fitto buio dei secoli posteriori. Accanto alla piccola chiesa di San Pietro - o di Sant’Agostino - per le esigenze della popolazione accresciuta, sorgerà un'altra chiesa più grande, dedicata alla Madonna Sancta Maria ad Cellas (celle dei monaci), volgarizzata in Santa Maria della Cella, che nel sec. XV sarà un fervoroso centro delle «Osservanze» liguri-lombarde, per merito precipuo di fra Paolo Vivaldi.
R. Bracco
Il complesso sorge nella zona sud-orientale di Sampierdarena, a poca distanza dalla linea costiera e dall'antico asse viario (via Dottesio e via D'Aste) su cui insistono le cinquecentesche ville dell'aristocrazia genovese. L'accesso attuale alla chiesa è stato realizzato nel 1860 con l'apertura di via Andrea Doria (oggi Giovannetti).
La chiesa odierna trae la sua origine da una precedente costruzione menzionata con certezza per la prima volta nel 752, anno in cui le ceneridi Sant'Agostino, provenienti dall'Africa, sbarcano nei dintorni di Genova durante il viaggio verso Pavia: è probabile che la primitiva chiesetta venisse restaurata in quella occasione per volontà del re longobardo Liutprando. La chiesa di Santa Maria della Cella, che trae nome dalla preesistente cappella, è costruita tra il 1206 e il 1213 per volontà di Jacopo di Borgo e Battistello Doria: l'edificio, con una struttura praticamente identica all'attuale, a tre navate, viene posto sotto l'alto patronato dei Doria; nel 1436, per decisione di papa Eugenio IV, lo stesso viene incorporato al monastero di San Benigno, sei anni dopo passa agli Eremitani lombardi, di regola agostiniana, cui rimane fino al 1797. Nel 1453, il corpo di fabbrica duecentesco è trasformato per iniziativa di Bartolomeo Doria, dando le attuali dimensioni al coro. Al primo periodo dell'insediamento agostiniano risale anche la sistemazione del chiostro, di cui rimangono poche tracce, simile ad altri edificati a Genova nel medesimo tempo. A partire dal Cinquecentio, sempre i Doria propiziano la trasformazione del volto gotico di Santa Maria della Cella con la sistemazione del coro a sacrario tombale della famiglia. Al 1639, risale la costruzione della cupola. Nel 1797, la necessità di disporre di una chiesa parrocchiale induce il governo democratico della Repubblica Ligure ad allontanare gli agostiniani. Anche nel corso dell'Ottocento la chiesa subisce parecchie trasformazioni, in particolare, nel 1850, si procede all'allungamento della navata e alla sistemazione della facciata. In anni più recenti si è dovuta lamentare la perdita di buona parte del chiostro, già colpito dai bombardamenti del secondo conflitto mondiale, sostituito da un edificio che ricalca solo vagamente le arcate originarie.
La chiesetta di Sant'Agostino fu decorata tra la fine del XII e il principio del XIII secolo con un ciclo di affreschi, dedicati alla vita di Cristo, i cui resti sono ora conservati nel salone parrocchiale. Praticamente nulla resta della decorazione del primo insediamento agostiniano. Intorno al 1650, l'Ordine dà mandato a Domenico Fiasella per ornare la volta del presbiterio con un soggetto, i Misteri di Maria, suddiviso in dieci medaglioni. La restante decorazione della chiesa, con scene della vita di San Martino, risale alla seconda metà dell'Ottocento ed è dovuta a Nicolò Barabino, anche autore della celebre Madonna dell'olivo. Tra le altre testimonianze artistiche, la Madonna col bambino e San Giovanni di Luca Cambiaso e il San Bernardo da Chiaravalle in preghiera davanti al Crocefisso di Giovanni Battista Castiglione detto il Grechetto.
Andrea Leonardi