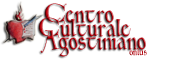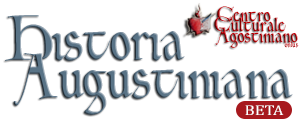La presenza dei padri Eremitani di Sant’Agostino in Ancona si può far risalire almeno sin dal 1280 (o forse prima, ai tempi di Urbano IV, 1261-1264), da quando cioè si ha notizia di un piccolo oratorio e un ristretto convento extra moenia, detto «Sant'Agostino Vecchio» costruito sul culmine del colle Astagno, presso il «Casseretto», a spese del Comune, demolito nel 1534 con gli sbancamenti per la costruzione della Cittadella fortificata di Antonio da Sangallo jr. Qui vissero il beato Guglielmo Bompiani e il beato Agostino Trionfi, che vi estese la sua Destructio sive eradicatio totius Arboris Porphyrili, che riporta appunto nel colophon: «Ancona actum est hoc opus anno gratiae 1280» (pubblicata a Bologna nel 1502). La nuova chiesa venne eretta fra il 1338 e il 1341 col titolo doppio di Sanctae Mariae Populi e Sancto Augustino, a seguito di un breve di Benedetto XII e per volere e spesa del Senato anconitano - a impetrare la protezione della Vergine e di San Nicola da Tolentino (al quale fu dedicata la cripta-oratorio sotterranea della Santa Requie, ovvero delle anime purganti) contro la peste che imperversava in quegli anni in città. Ne benedisse la prima pietra Giovanni II d’Ancona, frate minorita, allora vescovo di Senigallia, il 9 novembre 1338; il Priore del convento generalizio era Giacomo d’Ancona. La chiesa era posta strategicamente alla confluenza del colle dell’Astagno con quello di San Ciriaco, nella massima depressione orografica della città, alla base della via Grande (oggi Cialdini), allora unico accesso alla città dal litorale a nord. Con la sua abside orientata a ovest e direttamente affacciata sullo stretto litorale dorico, la chiesa sorgeva nel punto di maggior confluenza dei pellegrini, dei viaggiatori e dei mercanti provenienti da Roma e da Senigallia. Questi entravano in città scavalcando l’Astagno (Capodimonte) per la via Grande o passando sotto le sue Rupi a mare attraverso la porta di San Giacomo, eretta nell’aprile 1379 e demolita nel gennaio 1787 per la costruzione della nuova litoranea strada Pia. Forse fu proprio la sua felice collocazione urbanistica, tipica degli ordini mendicanti, a decretare il successo popolare della chiesa che, già dal secolo successivo (ingenti i lavori dal 1452 al 1497) risultava ampliata di un chiostro (1493), di un campanile (1496) c di un complesso di stanze con loggette verso mare, destinate ai novizi e a una piccola università religiosa (studium generalis). Durante questi lavori venne intonacato l’interno della chiesa, demolite alcune vecchie cappelle, realizzati il coro e l’altar maggiore (1482), terminante con una guglia con la statua di sant’Agostino. Vennero ampliate le stanze del convento realizzandone alcune sotto il presbiterio presso la cripta-oratorio delle Sante Requie, quindi la cucina e la campana grossa del campanile. Fu verosimilmente allora che l’abside, originariamente piatta, venne ristrutturata a pianta poligona come si vede in tutta l’iconografia storica della città. Venne infine realizzato un pozzo nel chiostro, generosamente messo a disposizione della popolazione (puteus publicus). Il tempio fu consacrato solo il 21 aprile 1560 dal vescovo di Segnia (in Dalmazia, ndr.) Giorgio Csivkovich, essendo priore M. Gabrieli di Ancona.
Non sappiamo quale fosse l’aspetto della facciata della chiesa originaria ma possiamo immaginarne il prospetto medievale a semplice capanna, aperto da un rosone posto con molta probabilità esattamente dove oggi è tamponato l’oculo a festoni, superiormente al portale. L’importanza oramai assunta dalla popolarità del tempio, e il desiderio d’emulazione, convinse gli Agostiniani a ingaggiare l’artista più famoso operante allora in città, già occupato nella facciata della Loggia dei Mercanti e in quella del San Francesco delle Scale. Lo strumento di allogazione del nuovo portale della chiesa fu stipulato tra i padri Agostiniani e il maestro croato Giorgio di Matteo in data 28 giugno 1460. Esso prevedeva un compenso di 650 ducati d’oro, dei quali 350 pagabili in moneta e 300 con la cessione di una casa di corrispondente valore posta in Ancona entro i confini della parrocchia di San Pietro, oltre all’uso gratuito di un altro locale prossimo all’edificio per il periodo di durata del cantiere. Il contratto fissava il termine per il completamento del portale marmoreo in tre anni dalla stipula, prescrivendo che la sua dimensione dovesse seguire in larghezza quella del portale in costruzione della chiesa di San Francesco delle Scale: «[...] latitudinis ad mensuram porta Ecclesia sancti francisci de scalis de ancona.», e in altezza giungesse: «[...] usque ad oculum magnum existentem in in faccie dicte Ecclesie usque ad partem subtaneam dicti oculi», fornendoci così una parziale ma interessante descrizione della preesistente chiesa trecentesca. I lavori s’interruppero nel novembre 1475 con la morte di Giorgio di Matteo, il portale fu portato a termine per opera di lapicidi di formazione padana che avevano lavorato a contatto con maestri del Rinascimento, come Francesco di Giorgio, nel palazzo della Signoria di Jesi e in quello del Governo di Ancona. I due artisti ai quali fu allogata, per 250 ducati d’oro nell’agosto del 1493 ed entro il termine di dodici mesi e mezzo per la consegna, la continuazione dell'opera di Giorgio, erano Michele di Giovanni da Milano e Giovanni Veneto; definiti nell’atto «famosissimi lapicidine». Ad essi fu commissionata circa un terzo della facciata: probabilmente quanto di incompiuto rimaneva. È da sottolineare però che a questi lapicidi si prescriveva di eseguire i completamenti «sequendo principium et cornpositionem factam per olim Magistrum Georgium», quindi non molto spazio veniva lasciato alla loro personale interpretazione del disegno compositivo originale del Maestro «designata in quadam carta mambrana subscripta», ossia il progetto su pergamena, vistato dal committente cioè dai frati, allegato al contratto originale ed evidentemente ancora in loro possesso. La parte scultorea del portale è senz’altro preponderante su quella architettonica, come spesso accade nelle opere di Giorgio di Matteo, e appare impostata su di un programma iconografico sicuramente suggerito dalla committenza che vi ha voluto rappresentare i temi tradizionali dell’iconografia agostiniana legata alla vita e agli epigoni del vescovo di Ippona. La prima statua, a sinistra dal basso, raffigura santa Monica; a destra compare la statua di san Nicola da Tolentino; i due santi nei baldacchini superiori sono san Simpliciano, a sinistra, e il beato Agostino Trionfi, a destra. Nel pennacchio centrale sotto l’architrave è raffigurata una scena dell’Annunciazione. Nella specchiatura centrale si staglia la storia scultorea di sant’Agostino vescovo che rigetta i libri eretici mostrando le pergamene della Sacra Scrittura, mentre i due angeli laterali sollevano il velo dell’ignoranza tirato in alto e annodato dal superiore semibusto scultoreo simboleggiante la Rivelazione (o la Fede), raffigurata con la fiamma frontale della Verità teologica. La composizione si conclude in alto col busto benedicente del Rector Mundi, un tempo posta a coronamento del grande festone circolare e oggi, insensatamente, postavi al centro dopo la ristrutturazione postunitaria.
Nella cripta-oratorio di San Nicola o della Santa Requie (sottostante la tribuna originaria della chiesa, era un tempietto di forma gotica a crociere costolonate su esili colonnine), venne fondata nel 1467 la Compagnia della Madonna del Popolo, curata dalla comunità dalmata in Ancona, cui venne concessa in perpetuo dai padri Agostiniani. Vi si ricorda la presenza di un affresco crivellesco attribuito a Ludovico Urbani da San Severino. Nell’allungamento quattrocentesco dell’abside vi furono affiancate nuove stanze per il noviziato, verso le mura a mare, poi collegate da un passaggio coi lavori del 1558. I locali vennero chiusi dal Vanvitelli nel 1750-1764, in parte destinati a ossario e in parte a bottega (le strutture sono in parte ancora esistenti, ma occultate e dimenticate a tutt’oggi, fra le stigliature dell’attuale negozio ortopedico).
Il 28 novembre 1554 venne decisa l’erezione di un altare dedicato a santa Barbara, protettrice dei bombardieri. Nel 1558 venne ingrandito il convento per soddisfare la continua affluenza di novizi, vennero probabilmente utilizzati i materiali della demolizione del complesso di Sant’Agostino Vecchio a Capodimonte. Sulla porta d’ingresso fu collocata l’iscrizione: «DIVI AUGUSTINI PLEBI APERTA DOMUS», ovvero «casa aperta ai figli di Sant'Agostino». Nel giugno 1561 venne concesso un altare ai fratelli della Compagnia della Madonna del Popolo. Dal 1562 al 1567 Giacomo Fontana realizzò, su disegno di F. Paciotto, il baluardo del Lazzaretto vecchio e quello di Sant’Agostino e le relative cortine di collegamento, che modificarono profondamente l’assetto urbano dell’area togliendo dall’isolamento il fronte mare del complesso agostiniano. Il 20 luglio 1609 moriva in Ancona l’insigne pittore vadese Federico Zuccari, che volle essere sepolto in Sant’Agostino e le sue spoglie vennero ospitate nella tomba di famiglia di Marco Jovitta; nonostante la fama universale dell’artista, di tale sepolcro si sono perse le tracce. Davanti all’altar maggiore, nel 1617, venne posto un grande ciborio tutto decorato e dorato che occupava tutta la larghezza della navata unica e raggiungeva le capriate, finanziato dal ricco mercante Andrea Cassotti, di famiglia bergamasca residente in Ancona, della quale comparivano varie arme nel tempio (rimosso nel 1750). Nella Relazione dello stato del Monastero dei PP. Agostiniani nella Città di Ancona (15 febbraio 1650) redatta da padre Antonio Antonizza in relazione alle previste soppressioni innocenziane, risultano ospitate nel convento quarantanove persone, tra sacerdoti, chierici, laici professi e novizi: era il maggiore della città per popolazione religiosa. Nel 1655 fu rifatto il portone ligneo nella facciata, come da iscrizione superstite. Dal giugno 1750, l’architetto Luigi Vanvitelli iniziò a far demolire il vecchio tempio per ricostruirlo completamente in più ampie dimensioni (oltre 60 metri di lunghezza), su commissione del priore Michelangelo Barboni - mantenendolo sempre su navata unica - con volte a botte e pennacchi e sei altari (più quello principale) separati da colonne binate, con presbiterio coperto da cupola circolare e ampio coro emiciclo a catino, separato da un peristilio esastilo dall’evidente derivazione palladiana. Contemporaneamente una nuova alta facciata, barocca e avvolgente con cornicione mistilineo, ne inquadrava il portale quattrocentesco che veniva miracolosamente preservato dalla distruzione. Coadiuvarono nella direzione dei lavori gli assistenti del Vanvitelli: Carlo Murena e Pietro Bernasconi. Ma l’interno vanvitelliano, terminato nel settembre 1764 per una spesa complessiva di oltre 20.000 scudi, priore Gian Nicola Reppi, ebbe breve vita. Con l’occupazione napoleonica, negli ultimi mesi del 1797 la chiesa venne requisita per ordine della municipalità filo francese (28 novembre) e ristrutturata a ospedale militare con farmacia. Ai frati venne concesso di ritirarsi in una parte del convento e il titolo (che riprese per breve tempo quello di Santa Maria del Popolo) fu trasferito alla chiesa collegiata di Santa Maria della Piazza. Con le soppressioni degli ordini religiosi del 1808, il 17 ottobre del 1809 tuttavia gli Agostiniani dovettero lasciare anche il convento, convertito in caserma, e radunarsi in quello di Mondolfo nel pesarese. Le truppe napoletane di Gioacchino Murat entrarono in Ancona nel settembre del 1813, prendendo alloggio nel complesso agostiniano. Con la Restaurazione di Pio VII, nel 1822 i padri poterono rientrare nella loro chiesa. Ma di nuovo, con l’occupazione austriaca del luglio 1849, le truppe del generale von Pfantzelter ripresero alloggio nel complesso agostiniano. Con l’Unità d’Italia e i decreti del Commissario Valerio (1860-61) i beni degli enti ecclesiastici passavano all’amministrazione della Cassa ecclesiastica dello Stato, pur consentendo ai religiosi di dimorare ancora nei loro conventi ma senza assumere nuovi adepti. L’azione del Governo italiano ebbe compimento con la Legge del 7 luglio 1866, con la soppressione delle corporazioni religiose e l’incameramento definitivo dei beni e delle mense vescovili; parte dei beni mobili vennero messi all’asta. Nel 1871 la chiesa venne definitivamente concessa dal Comune all’Amministrazione militare; entro il 1874 l’interno della chiesa venne definitivamente demolito, e tripartito nell'altezza per ricavarvi i locali della nuova caserma Cialdini, sorretti da otto nuovi pilastri cruciformi su tre piani. Anche la facciata settecentesca fu demolita e il portale superstite di Giorgio di Matteo inscritto nell’attuale anonima facciata dal bugnato casermiero. Il campanile quattrocentesco venne mozzato, le due campane vennero poi vendute (nel 1883) al vescovo F. Marinelli O.S.A. e da questi donate alla basilica di San Nicola di Tolentino. L’abside poligonale venne tagliata, la porzione verso mare isolata e adibita a scala per un palazzo d’abitazione, il palazzo ex Appannaggio, poi inglobata nel nuovo edificio della Banca d’Italia dopo la seconda guerra mondiale, ciò per permettere l’abbattimento definitivo dell’antico arcone (arco di Sant’Agostino) che la sottopassava e quindi agevolare l’allargamento della nuova strada litoranea d’accesso in città. L’antica cappella della Santa Requie divenne allora parte occulta di nuove botteghe, come anche i probabili resti di affreschi quattrocenteschi raffiguranti la Misericordia coi santi Agostino e Nicola, coperti da nuovi intonaci, che le cronache locali attribuiscono al citato Urbani. L’insigne tempio agostiniano era stato, nel tempo, abbellito da notevoli opere pittoriche, in parte disperse, di Mariano da Perugia, Lotto, Filippo Bellini, Tibaldi, Brandi, Corvi, Roncalli, Peruzzini, Lilli, Lazzarini, Donnini, Galli, Pallavicini e dalle statue di Varlè. Alcuni arredi marmorei vanvitelliani (balaustra e altare) furono trasportati nella chiesa parrocchiale di Varano presso Ancona. Nel novembre 1894, l’architetto Giuseppe Sacconi, allora soprintendente ai Monumenti per le Marche, fece restaurare uno dei pilieri (non specifica quale) del portale a spese dell’Ufficio del Genio militare, essendo allora la chiesa sede del Distretto. Il portale quattrocentesco - ultimo reperto dell’ex chiesa di Sant’Agostino - risparmiato dal terremoto del 1972, è stato recentemente oggetto di un completo restauro (1991, su progetto dello scrivente) a spese della Direzione del Genio per la Marina del Ministero della Difesa, attuale proprietario del complesso ex agostiniano adibito oggi a Circolo ufficiali.
Fabio Mariano