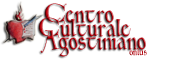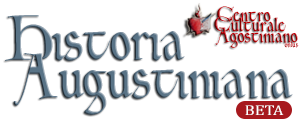Nel 1596 gli Agostiniani Scalzi si insediano anche nello slargo appena appartato dell'odierna piazzetta Marchi, uno spazio urbanisticamente dipendente dalla più nota chiesa conventuale di Nostra Signora Assunta, detta anche «la Madonnetta». La felice collocazione è intuita da Federico Alizeri che nel 1846-'47 scrive (F. Alizeri, Guida illustrativa per la città di Genova, p.520): «l'umile strada [...] per lieve ascendere guadagna d'altezza, così giunti al sommo, ci gioverà, indietreggiando con gli occhi alla valle, squadrar come in pianta il quadrangolo dell'ampio Albergo [dei Poveri], con entro i vani delle sue piazze [...]».
La fondazione è autorizzata dal serenissimo Senato della Repubblica di Genova nel 1596: davvero importante per le sorti dell'insediamento agostiniano è l'incontro con la nobile famiglia dei Moneglia che, proprietaria di alcuni terreni fuori dalla Porta Carbonara, si dimostra interessata a finanziare la costruzione di un convento. Il canteire della chiesa, tradizionalmente attribuito ad Andrea Ceresola detto il Vannone, è senza dubbio attivo tra il 1597 e il 1598, mentre nel 1599 è stipulato un contratto tra Giovanni Moneglia e il magister antelami Cipriano Bianco riguardante la sola costruzione monastica: a questa fase è riconducibile il corpo che sovrappone il dormitotio al blocco funzionale composto da refettorio, cucine e, nell'ammezzato, da un piccolo oratorio interno. Il lato a monte del futuro chiostro, da intendersi come estensione del cantiere diretto da Cipriano Bianco, è invece probabilmente riconducibile al 1614. Proprio tra il 1614 e il 1616 il Capitolo agostiniano stipula poi con Bartolomeo Bianco, figlio di Cipriano, il contratto per i quattro piani che compongono la manica disposta perpendicolarmente al volume chiesa-refettorio: il cantiere è preceduto da una lunga campagna di scavo e di preparazione dell'area affidata a Gio e Nicolò Mazza nel 1607, ancora in esecuzione nella primavera del 1671 sotto la direzione dello stesso Bartolomeo Bianco. Vanno inoltre ricordati la lastricatura della piazza (1618), il completamento del chiostro (1638), la realizzazione della libreria (1642-'43), il raddoppio in profondità della cappella di San Nicolò (1663), l'infermeria (1671-'72) e i lavori per la nuova sacrestia e il nuovo coro (1680-'85), elementi da considerare il definitivo completamento del programma edilizio avviato tra il 1614 e il 1617.
La chiesa ha un vano unico con decorazioni a stucchi di gusto barocchetto e cappelle ricche di marmi. La controfacciata è decorata con un affresco di Lazzaro Tavarone, mentre nella seconda cappella a destra è conservato un gruppo ligneo di Pasquale Navone raffigurante San Nicolò con la Madonna e le anime purganti. Ancora, sopra l'altare maggiore, è collocata una Madonna del parto attribuita a Tommaso Orsolino. Ai lati del presbiterio, trovano posto due portali di marmo intarsiati del 1656. Nella seconda cappella a sinistra, due dipinti di Gio Battista Paggi, I profanatori del tempio e Le nozze di Cana, affiancano una statua della Madonna di Taddeo Carlone. Sempre a sinistra, nella prima cappella, sono collocate due tele settecentesche raffiguranti un Sant'Agostino e una Santa Monica, insieme a una Madonna della Consolazione di Bartolomeo Guidobono.
Andrea Leonardi